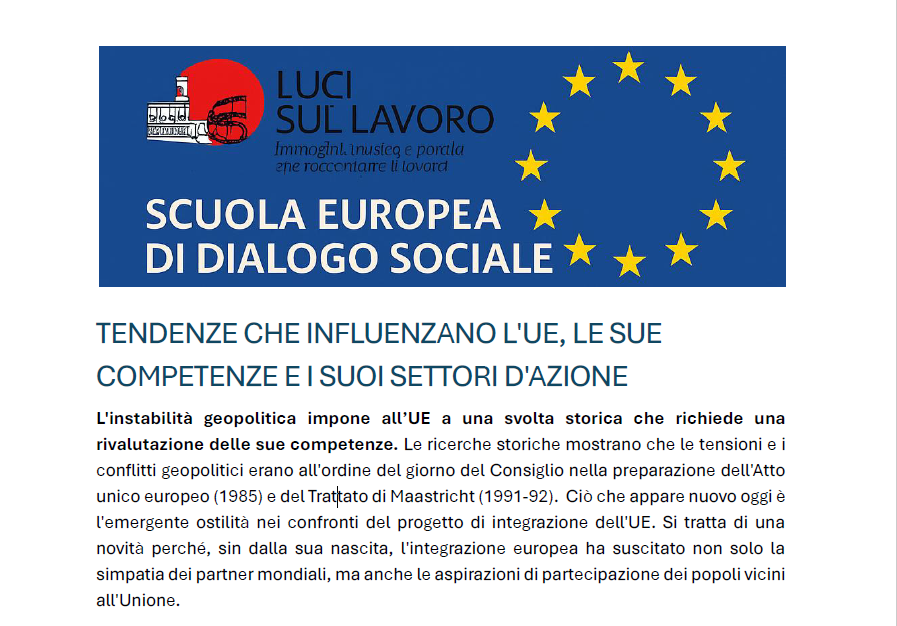
TENDENZE CHE INFLUENZANO L’UE, LE SUE COMPETENZE E I SUOI SETTORI D’AZIONE
L’instabilità geopolitica impone all’UE a una svolta storica che richiede una rivalutazione delle sue competenze. Le ricerche storiche mostrano che le tensioni e i conflitti geopolitici erano all’ordine del giorno del Consiglio nella preparazione dell’Atto unico europeo (1985) e del Trattato di Maastricht (1991-92). Ciò che appare nuovo oggi è l’emergente ostilità nei confronti del progetto di integrazione dell’UE. Si tratta di una novità perché, sin dalla sua nascita, l’integrazione europea ha suscitato non solo la simpatia dei partner mondiali, ma anche le aspirazioni di partecipazione dei popoli vicini all’Unione.
Fino a pochi anni fa l’UE era associata alla stabilità, all’equità e alla sostenibilità. Nel nuovo millennio, l’Unione ha incorporato nuovi 12 stati (molti dei quali sotto la sfera di influenza sovietica nel XX secolo). Le nuove sfide in materia di capitale stanno scuotendo l’architettura istituzionale generale dell’UE.
Un’ostilità così manifesta nei confronti dell’UE è una sfida esterna mai sperimentata a cui l’UE è chiamata a reagire, dando forza ai suoi Stati membri ma navigando tra incertezze istituzionali e l’ambiguità del mandato conferitole. L’espansione militare russa, il terrorismo, la posizione competitiva (se non ostile) degli Stati Uniti e dei BRICS: ci si aspetta che l’UE sia un fornitore di sicurezza da parte di una comunità di persone che vuole essere rassicurata sulla capacità delle sue istituzioni di gestire molteplici sfide. Richiede una strategia di sicurezza multiforme che già oggi sta ampliando il campo d’azione dell’UE e che ha un impatto evidente sull’occupazione, sui diritti dei lavoratori e sulle relazioni industriali.
Prima di tutto la sicurezza economica. L’Unione Europea ha plasmato una politica industriale a tutti gli effetti, culminata nella Bussola della Concorrenza e nel Clean Industrial Deal. Fatica a conquistare un’autonomia strategica (aperta) per fronteggiare l’interruzione delle catene di approvvigionamento, per contendersi le materie prime e critiche e sviluppare tecnologie strategiche. Ciò ha implicazioni sociali significative sui posti di lavoro, sul modo in cui lavoriamo e richiede transizioni rapide e rapidi miglioramenti della produttività.
La seconda dimensione è la sicurezza territoriale. Con la nuova configurazione della guerra ibrida, la bussola strategica proietta l’Unione verso un’Unione della difesa senza un trattato sulla difesa. Queste dimensioni non riguardano solo il programma Rearm o del fondo SAFE. Ciò ha molto a che fare con il nuovo concetto di conflitti ibridi, comprese le tecnologie a duplice uso e l’uso bellicoso dei nuovi media e delle reti sociali. Per combattere la disinformazione è necessario che l’UE agisca in settori strategici fortemente connessi all’esercizio delle libertà fondamentali, al centro delle nostre democrazie, come la formazione dell’opinione pubblica, la regolarità delle elezioni negli Stati membri dell’UE o l’opposizione all’incitamento all’odio e agli interventi stranieri volti a destabilizzare la coesione sociale.
L’azione invasiva ma necessaria dell’Unione nel settore delle libertà fondamentali quali la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà d’impresa (si veda la causa T-125/22 RT Francia contro Consiglio) può potenzialmente avere un impatto su prerogative sindacali quali l’azione collettiva, l’esercizio dei diritti sindacali e il diritto di essere rappresentati sui luoghi di lavoro. E questo è un fatto nuovo nella vita dell’UE.
La terza dimensione è la sicurezza sociale. Questa dimensione è maturata negli ultimi anni, lasciando all’Unione Europea la necessità di garantire la salute delle persone (ad esempio, contro le pandemie), il loro reddito, l’indipendenza energetica o di proteggere le persone dalla disinformazione e dalle interferenze nella vita democratica dei paesi da parte di minacce esterne. Inoltre, la stabilità sociale integra l’agenda della sicurezza, in modo che la lotta alla povertà come il reddito minimo, il controllo dei prezzi dell’energia e dei beni essenziali e i salari minimi, solo per citarne alcuni, entrino (o dovrebbero essere una componente) dell’agenda della sicurezza dell’UE. Si amplia la sfera delle politiche sociali dell’UE, senza essere necessariamente incentrata sull’occupazione e sulla protezione del lavoro e con progressiva marginalizzazione del dialogo sociale.
La questione qui non riguarda la necessità dell’UE di agire, ma piuttosto la legittimazione democratica dell’azione dell’UE nell’ambito dell’attuale regime istituzionale. CI si chiede se i trattati dell’UE forniscano un giusto equilibrio di interessi nel modo in cui l’UE opera in una situazione di emergenza persistente. Si è fatto notare che l’ultima revisione dei Trattati risale al 2007, nata dalle ceneri del fallito tentativo di dare una Costituzione all’Unione Europea. Il trattato di Lisbona non è riuscito ad ampliare le competenze dell’UE o a migliorare l’efficienza del processo decisionale, ad esempio con un uso esteso del voto a maggioranza qualificata. Non è riuscito ad adeguare il bilancio europeo e a rafforzare l’ancoraggio dell’ordinamento giuridico dell’UE ai diritti fondamentali internazionali. Ciò ha lasciato l’UE a malapena attrezzata per gestire le crisi successive, tra cui la crisi finanziaria, la pandemia di COVID-19 e le turbolenze geopolitiche in corso.
Dopo il 2020, il posizionamento dell’Unione europea (UE) nelle dinamiche globali è caratterizzato da dichiarazioni chiave e agende strategiche, in particolare le dichiarazioni di Versailles (2022) e Granada (ottobre 2023) e l’agenda strategica 2024-2029 del Consiglio europeo. Poco note al grande pubblico, esse hanno influenzato il programma quinquennale della Commissione europea dopo le elezioni europee del 2024. Sono il segno di una comunità di Stati che vede nelle istituzioni comuni dell’UE un grande potenziale, ma fatica ad offrire a tali istituzioni lo spazio democratico che meritano.
I limiti istituzionali dell’ultima riforma del trattato del 2007 sono diventati improvvisamente evidenti. Un anno dopo, era il 2008, una crisi finanziaria globale ha posto l’UE di fronte a una sfida capitale che ha causato un progressivo ampliamento delle sue competenze per proteggere l’unione monetaria e gestire i rischi fiscali degli Stati membri. Per un decennio l’UE ha navigato in un territorio inesplorato con risultati controversi. Tra il 2008 e il 2014, una serie di interventi politici, tra cui interferenze nella determinazione dei salari e nel funzionamento della contrattazione collettiva, ha bruscamente interrotto il processo di convergenza verso l’alto delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori europei e delle loro famiglie.
La tensione tra solidarietà e interessi nazionali ha spostato l’equilibrio a favore della seconda e condotto a misure punitive nell’assistenza finanziaria agli Stati membri, esemplificate nella crisi del debito greca. L’istituzione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e le politiche della Banca centrale europea hanno segnato un timido passaggio verso una vera e propria assistenza reciproca tra gli Stati membri. Tuttavia, la sentenza della Corte di giustizia europea nel caso Pringle (causa C-370/12, Thomas Pringle contro governo irlandese), pur legittimando il MES, sembra confermare che il concetto di solidarietà di cui all’articolo 122 può essere interpretato come assistenza finanziaria temporanea e solo quando si agisce in caso di emergenza. Un interpretazione molto restrittiva alla solidarietà. Utilizzando gli strumenti di emergenza del Trattato, per lo più lo spazio offerto dal Titolo VII (articoli da 120 a 126 del TFUE), a diversi paesi sono state imposte riforme draconiane che oggi sono conosciute con il concetto autoesplicativo di “austerità”.
Gli effetti sulle condizioni di vita degli europei sono stati devastanti, lo certificano diverse analisi e dati. Nel 2015 la nuova Commissione europea, guidata dal Presidente Juncker, ha chiesto un ruolo politico nella governance economica dell’euro. La
proclamazione del Pilastro europeo dei diritti sociali ha rilanciato l’iniziativa legislativa dell’UE nel settore sociale. Questo cambiamento politico ha probabilmente aperto la strada a future iniziative come il Next Generation EU (NGEU), SURE, e il debito pubblico europeo per gli investimenti, quando nell’ambito della crisi pandemica ha spinto l’UE a comportarsi come uno Stato federalista e a superare resistenze a cui alcuni si opponevano in nome di alcuni interessi nazionali.
Tuttavia, l’attuale modello di integrazione incentrato sul mercato tende a relegare gli obiettivi sociali in secondo piano rispetto alle priorità del semestre europeo. È stato denunciato dal movimento sindacale europeo quando ha chiesto un Protocollo sul Progresso Sociale, una proposta poi fatta propria dalla Conferenza sul Futuro dell’UE nel 2023. Il disequilibrio negli obiettivi fondamentali dell’UE può essere visto come uno dei motivi per cui le parti sociali continuano a faticare nel trovare un coinvolgimento significativo nei recenti programmi che sostengono le riforme e le politiche di investimento dell’UE, anche quando questi programmi hanno un chiaro impatto sul modo in cui lavoriamo, produciamo e consumiamo.
Ad esempio, SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) ha contribuito in modo significativo all’armonizzazione della legislazione nazionale in materia di regimi di riduzione dell’orario lavorativo per proteggere l’occupazione durante le crisi. Tuttavia, le considerazioni finanziarie hanno spesso prevalso sugli sforzi volti ad allineare la conservazione dell’occupazione ad altri obiettivi socialmente rilevanti, come il miglioramento dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro o la lotta alle disparità di genere, come previsto dal pilastro europeo dei diritti sociali.
Gli studi di Eurofound e della CES indicano che il coinvolgimento delle parti sociali nell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) è stato minimo o del tutto evitato. Inoltre, al momento di presentare i piani strutturali di bilancio a medio termine (come previsto dalla riforma del patto di stabilità e crescita del 2024), tutti gli Stati membri hanno invocato la clausola di deroga di cui al regolamento (UE) 2024/1263, che li esonera dall’obbligo di coinvolgere le parti sociali nella presentazione del primo piano strutturale.
Resta il fatto che gli attuali trattati sembrano essere inadeguati a trovare il giusto equilibrio tra politiche economiche, sociali, di sostenibilità e fiscali in un mondo che sta attraversando cambiamenti traumatici. Di fronte alle emergenze, la risposta comune europea richiede spesso misure correttive, straordinarie e temporanee se si vuole rispettare l’attuale quadro normativo e istituzionale dell’UE. Il riferimento qui è ancora una volta all’articolo 122 del TFUE, in cui il concetto di solidarietà può spaziare
dalle chiavi distributive delle risorse raccolte nell’ambito dello strumento europeo per la ripresa e dello strumento di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) all’attivazione meno solidaristica delle clausole di salvaguardia previste dal patto di stabilità e crescita. La tensione tra l’approfondimento del mercato unico e i limiti del quadro istituzionale dell’UE, come evidenziato dal rapporto Letta sul mercato unico, richiede un nuovo equilibrio.
L’UE ha bisogno di un modo diverso per finanziare le sue politiche in materia di investimenti e le sue politiche, compresi gli investimenti sociali e i quadri politici. Più recentemente, il programma ReArmEU esplora una combinazione di flessibilità fiscale per la spesa militare e uno strumento dell’UE, l’azione per la sicurezza per l’Europa (SAFE), che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri consentendo loro di effettuare investimenti pubblici urgenti e importanti a sostegno dell’industria europea della difesa. Al fine di finanziare il sostegno nell’ambito dello strumento SAFE sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere, a nome dell’Unione, di contrarre prestiti sui mercati dei capitali o presso un istituto finanziario (come il Gruppo BEI o il MES).
Ancora una volta l’articolo 122 del TFUE funge da base giuridica, lasciando così inosservata la definizione di solidarietà e di condizionalità sociali a cui gli Stati membri dovrebbero essere soggetti al momento della presentazione delle richieste di finanziamento. D’altro canto, le esperienze SURE (strumento per l’occupazione), RRF (strumento per investimenti e riforme), STEP (strumento per sviluppo tecnologie strategiche) e SAFE (strumento per la difesa) portano consenso a coloro che sostengono l’istituzione di un fondo permanente dell’UE per gli investimenti, l’aumento delle risorse proprie dell’UE e l’aumento della capacità dell’UE di emettere debito comune. Per fare di questi strumenti un veicolo di unità, coesione e solidarietà tra i popoli dell’UE, resta tuttavia necessario e urgente una revisione dei trattati dell’UE.
Le politiche sociali e del lavoro dell’UE sono limitate dalla dicotomia tra l’articolo 148 (coordinamento delle politiche nazionali) e l’articolo 153 del TFUE (legislazione sulle norme minime). Dal 2017, il Pilastro europeo dei diritti sociali e il suo piano d’azione mirano a integrare le politiche fiscali, economiche e sociali all’interno del mercato unico. Allo stesso tempo, l’attuale ancoraggio (per lo più esterno) ai diritti fondamentali sta dimostrando i suoi limiti e deve essere considerato alla luce dell’espansione o meno delle competenze dell’UE. Il dialogo sociale europeo rimane una pietra miliare delle politiche sociali dell’UE volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, promuovere la coesione sociale e garantire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.
La ricerca storica di SHAPE spiega l’importanza sancita dall’Accordo di Maastricht del 1991, che ha integrato il dialogo sociale nella politica sociale dell’UE, conferendo alle parti sociali un’autorità quasi legislativa. Questo ruolo è stato affermato dal Tribunale di primo grado nella sentenza Ueapme contro Consiglio nel 1998. Il successo iniziale dell’accordo sulla politica sociale di Maastricht ha portato alla creazione di direttive sul congedo parentale, sul lavoro a tempo parziale e sul lavoro a tempo determinato, tutte nate da accordi tra le parti sociali. Tuttavia, negli anni successivi si è assistito a uno spostamento verso il metodo aperto di coordinamento, in cui il ruolo dell’UE si è concentrato sugli orientamenti politici piuttosto che sull’azione legislativa diretta. Nel corso degli anni, questo metodo si è evoluto nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, fiscali e sociali degli Stati membri.
All’inizio del XXI secolo, il dialogo sociale ha assunto una natura più autonoma, che ha portato ad accordi quadro da attuare attraverso accordi nazionali delle parti sociali. Tuttavia, l’attuazione pratica di questi accordi si è rivelata difficile a causa dei diversi contesti nazionali e della riluttanza delle organizzazioni dei datori di lavoro a impegnarsi in impegni vincolanti. Questa riluttanza è in parte dovuta alla mancanza di un mandato negoziale, che funge più da lobby che da attore negoziale. Il sostegno della Commissione europea al dialogo sociale ha subito fluttuazioni dopo il “momento Delors”, con un notevole calo durante l’era Barroso. La crisi economica del 2009 e le successive misure di austerità hanno ulteriormente indebolito il dialogo sociale, decentralizzando la contrattazione collettiva e minando il modello sociale europeo.
L’approvazione del pilastro sociale europeo a Göteborg ha segnato un rilancio della legislazione dell’UE in materia di lavoro, portando a significative iniziative legislative che hanno coinvolto le parti sociali [Tra le direttive degne di nota si segnalano: equilibrio tra attività professionale e vita familiare (2019/1158/UE); condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (2019/1152/UE); direttive sulle piattaforme digitali e sui salari minimi adeguati (2022/2041/UE); Comunicazione societaria sulla sostenibilità e due diligence (2024/1760/UE), Direttiva 2023/970 sulla Parità Salariale Uomo-Donna]
Tuttavia, il racconto degli anni dell’austerità ha segnato una svolta rilevante per gli attuali contesti del dialogo sociale europeo. La sentenza EPSU vs. Commissione del 2021 ha introdotto una nuova interpretazione dell’articolo 155 TFUE, conferendo alla Commissione la discrezionalità di presentare o meno gli accordi delle parti sociali al Consiglio, diminuendo così il potere quasi-legislativo del dialogo sociale. Ciononostante, l’UE continua a sostenere il dialogo sociale attraverso strumenti normativi non vincolanti, volti ad aumentare la copertura dei contratti collettivi all’80% dei lavoratori, come riecheggiato nella direttiva sul salario minimo adeguato.
7
Nel gennaio 2023 la Commissione ha rafforzato il suo impegno a favore del dialogo sociale attraverso comunicazioni e raccomandazioni agli Stati membri. Questi sforzi mirano a rafforzare le dimensioni trilaterale e bilaterale del dialogo sociale, garantendo il sostegno legislativo e una maggiore copertura della contrattazione collettiva. La dichiarazione interistituzionale di La Hulpe dell’aprile 2024 sottolinea ulteriormente l’impegno a rafforzare la dimensione sociale nella prossima legislatura, compresa la nomina di un responsabile del dialogo sociale in tutte le DG della Commissione.
A conclusione di questo capitolo, si può affermare che la storia di successo dell’Unione europea richiede sforzi costanti verso una maggiore integrazione. Il dialogo sociale ha offerto un contributo sostanziale in tal senso, ma il quadro istituzionale dell’UE presenta squilibri e obsolescenza. Le prossime legislature dovranno riguardare l’architettura istituzionale, i processi decisionali e i controlli e gli equilibri necessari per un’unione politica più intensa. Il raggiungimento di questo obiettivo garantirà un futuro prospero all’UE, promuovendo la coesistenza pacifica tra i suoi popoli e oltre.
Anche il dialogo sociale europeo si è evoluto, affrontando varie sfide e trasformazioni. Sebbene l’impatto legislativo sia diminuito, gli sforzi e gli impegni rinnovati indicano un impegno costante a rafforzare la dimensione sociale all’interno dell’UE, adattandosi alle sfide contemporanee e promuovendo lo sviluppo inclusivo in tutti gli Stati membri.
L’estensione dell’ambito d’azione e delle competenze dell’UE non è l’unica sfida per la dimensione sociale e il dialogo sociale dell’UE. Mentre l’UE è alla ricerca di una nuova posizione nel contesto globale in evoluzione, il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e ciò aggiunge una nuova dimensione alle politiche sociali dell’UE e al dialogo sociale.
